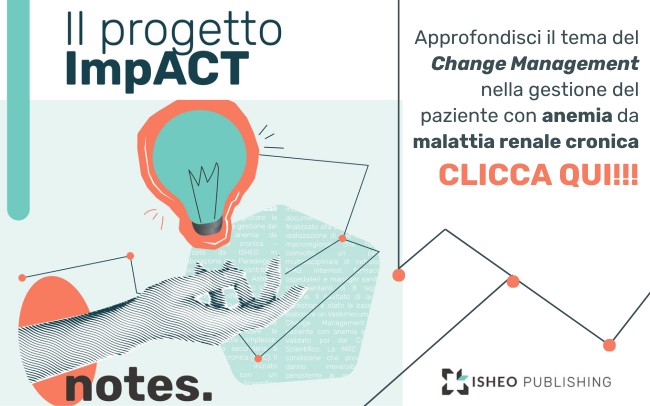La tecnologia è sempre stata un’estensione della mente, per cui la definizione stessa di ‘artificiale’ è intrinsecamente legata alla ‘naturale’ capacità cognitiva umana di sviluppare nuovi dispositivi che accompagnano l’evoluzione delle nuove tecnologie cognitive. Ma quali sono i possibili effetti della digitalizzazione sui processi neuro-cognitivi coinvolti nella comunicazione sociale e nella costituzione del senso di sé, soprattutto nel contesto dell’aumento del tempo trascorso online? E’ stato chiesto al neuroscienziato italiano di fama mondiale Vittorio Gallese, professore ordinario di Psicobiologia presso l’Università di Parma, che oggi a Firenze ha inaugurato il 62esimo Congresso Nazionale della SNO – Scienze Neurologiche Ospedaliere con la lettura magistrale dal titolo ‘Visioni digitali. L’esperienza di sé e degli altri nell’era della rivoluzione digitale’.
Professore, in che modo la tecnologia ha cambiato la modalità con cui le persone si relazionano con la realtà quotidiana? “Chi siamo è un processo dinamico, perché la vita ci cambia. Un aspetto che in particolare contribuisce a farci diventare ciò che siamo sono le pratiche sociali, cioè il modo con cui entriamo in relazione con gli altri. Ma questo modo è sempre stato determinato dal tipo di tecnologia disponibile. Pensiamo al Paleolitico, in cui la tecnologia è il fuoco e gli uomini ci si siedono attorno raccontandosi delle storie. È lì che nasce l’istinto narrativo. D’altronde creare immagini e raccontare storie sono le due ‘ossessioni’ del genere umano, i due aspetti (solo in parte legati al linguaggio) che ci contraddistinguono dalle altre creature viventi. Il fuoco è una tecnologia, così come lo sono la carta, l’invenzione della scrittura e della stampa a caratteri mobili, il telefono, il cinema, la radio, la televisione, il computer, lo smartphone e i social network”.
Parlando dei social network, in particolare, quanto determinano lo stile delle nostre relazioni sociali? “Sempre di più, ma non dobbiamo essere apocalittici: non dobbiamo demonizzare la tecnologia perché noi siamo naturalmente tecnologici, cioè la tecnologia è la naturale espressione del nostro essere esseri umani. Da Platone in poi, che demonizza la scrittura (affermando che la poesia, la tragedia e l’arte sono una copia della realtà, che a sua volta è una copia del mondo delle idee) siamo abituati ad una periodica alzata di dito da parte di qualcuno che pensa che questo sia l’inizio della distruzione dell’umanità. Ma queste considerazioni le lasciamo ai tromboni che abbondano nel nostro Paese. Certamente queste tecnologie, proprio perché modificano il nostro stile di vita, vanno comprese, studiate e soprattutto regolate. Non sto parlando tanto dei social network, quanto dell’intelligenza artificiale, altro grande demone di cui si parla dalla mattina alla sera. Il vero problema non è tanto che queste tecnologie esistono, ma di chi sono e soprattutto come vengono utilizzate”.
Esistono rischi effettivi per i giovani che usano troppo la tecnologia? “Sono usciti diversi lavori, anche su riviste di neurologia molto prestigiose come ‘Brain’, in cui sono stati segnalati casi di adolescenti che andavano dal medico perché mostravano dei tic motori, delle stereotipie del comportamento, che facevano pensare alla sindrome di Gilles de la Tourette. In realtà non si trattava di questa sindrome, perché questa può essere diagnosticata neurologicamente, ma di una esposizione smodata e continuativa a filmati di YouTube che mostravano pazienti epilettici che riprendono le proprie crisi e le pubblicano online, facendo peraltro milioni di ascolti, o di pazienti con la sindrome de la Tourette. Quindi erano forme di isteria di massa mediate dal medium digitale. Questo è uno spunto per dire che le tecnologie non sono né buone né cattive, ma tutto dipende dall’uso che ne facciamo. Se noi non usciamo mai di casa e restiamo 12/14 ore al giorno davanti allo schermo entriamo certamente nella patologia, nella sindrome di Hikikomori, con adolescenti che praticamente si ritirano dal mondo, ordinano il cibo online e non escono più. Ma fortunatamente questo è un fenomeno marginale”.
Insomma, come lo vede il bicchiere? “Diciamo che il bicchiere lo si può vedere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma con i proclami apocalittici, lo ripeto, non si va da nessuna parte: pretendere di mettere una moratoria allo sviluppo delle tecnologie è come voler vuotare il mare con il cucchiaio. È impossibile. Credo che da questo punto di vista l’Europa sia meglio equipaggiata degli Stati Uniti, nel senso che è consapevole di alcuni rischi ed è a lavoro su linee guida che possano disciplinare l’uso di questi strumenti da parte dei gestori. Parliamo di Microsoft, Google, Amazon, Metaverse, Elon Musk, insomma dei big player che hanno le carte in mano e budget incredibili con cui peraltro sottraggono sempre di più ricercatori anche dalle ricchissime università americane. Perché un ingegnere informatico lascia Stanford o Harvard per andare a lavorare per Google? Non tanto o non solo perché viene pagato di più, ma perché queste compagnie possono offrire ai ricercatori qualcosa che le università non sono in grado di dargli, cioè i dati”.
Servirebbe un’educazione digitale rivolta soprattutto alle nuove generazioni? “Un aspetto se vogliamo negativo che si può trovare in questa prevalenza del digitale non sono tanto le fake news, che ci sono sempre state, pensiamo alle fotografie ritoccate di Lenin con a fianco Trotski, che poi viene eliminato dall’immagine, ma la mancanza di un’educazione digitale. Il tentativo di confondere le idee, modificando le notizie e le immagini, è una storia vecchissima. Quello che manca allora è proprio un’alfabetizzazione digitale, nessuno insegna mai agli studenti come fare una ricerca online. Le tecnologie sono strumenti incredibili e l’accesso al sapere è straordinariamente moltiplicato, ma servono strumenti per usarle correttamente e approfittarne al meglio”.
Poca educazione digitale, ma anche poca ricerca sui rischi/benefici della tecnologia. È così? “I dati sono pochi e ancora molto controversi: ad esempio ci sono ricerche che sembrano mostrare che un dato scritto a mano viene memorizzato meglio di un testo scritto su una tastiera digitale, ma c’è chi sostiene il contrario. Il quadro non è ancora del tutto chiaro: c’è molta ricerca fatta in privato da compagnie, ma a livello istituzionale, nonostante se ne parli, si fa poca ricerca”.
Parliamo dei falsi miti legati alla tecnologia. Qual è il primo che le viene in mente? “Un luogo comune oggi è che i ragazzi sono violenti perché giocano ai videogame violenti. Ma anche questo è un punto controverso, ci sono studi che dimostrerebbero che non è vero. Aggiungo che la storia, anche del nostro Paese, ha conosciuto epoche molto più violente, pensiamo a quando muravano il Conte Ugolino insieme ai suoi figli. Eppure al tempo i videogame non esistevano. Cerco di avere un approccio empirico e prima di prendere una posizione voglio vedere ricerche, dati e numeri”.
Ma cosa possono cambiare in noi, o di fatto cambiano, queste tecnologie? “La nostra capacità di mantenere per lunghi periodi dei livelli di attenzione. Se parliamo dell’audiovisivo, ed è stato dimostrato anche quantitativamente, il ritmo e il montaggio nei film e nelle serie tv è progressivamente accelerato dagli anni Trenta fino ai giorni nostri e oggi assume proporzioni che fanno venire quasi il mal di mare. Il tempo medio che i miei figli passano davanti ad un video su TikTok, per fare un esempio, è di pochissimi secondi. Allora se il nostro cervello viene sistematicamente allenato ad un livello di attenzione che ha una finestra temporale sempre più corta, poi fa fatica a mantenere questa attenzione per un periodo molto più lungo, come quando si vuole leggere un romanzo o studiare un libro di duecento pagine. Pensiamo anche agli articoli di quotidiani o settimanali online, ormai quasi tutti all’inizio indicano quanti minuti si impiegano a leggerli. Evidentemente è un qualcosa che serve ad invogliare le persone, ma di certo è sintomo di una modificazione in atto determinata dall’uso costante di tecnologie”.
L’uso della tecnologia, come diceva, ormai è diventato costante. Basti pensare allo smartphone, lo abbiamo sempre tra le mani… “Un altro aspetto legato alla tecnologia, anche se aneddotico perché non c’è nulla di scientifico, è che oggi con lo smartphone godiamo/soffriamo di una perenne reperibilità che innesca dei meccanismi ansiosi terribili. Quando da ragazzino andavo in vacanza, appena arrivato cercavo il primo telefono a gettoni per telefonare a casa e avvertire che andava tutto bene; lo stesso facevo il giorno della ripartenza. Due sole telefonate e la mia famiglia era tranquilla, nonostante fosse una società meno permissiva rispetto a quella di oggi. Oggi se non si risponde subito al telefono scatta immediatamente l’allarme. Sempre legato all’uso dello smartphone ci sono poi aspetti, chiamiamoli, ‘narcisistici’. Una volta si faceva l’esperienza e poi magari la si documentava facendo una foto, oggi in molte persone viene il sospetto che l’esperienza venga fatta solo ed esclusivamente per poterla documentare e rendere pubblica. È un’inversione del rapporto: vivo e poi documento, documento per vivere, cioè la mia vita è una continua narrazione audiovisiva”.
Negli anni è aumentata questa nostra perenne ricerca di apprezzamento oppure è solo una percezione? “Diciamo che una delle caratteristiche dell’uomo è il desiderio di essere riconosciuto dall’altro e oggi questo desiderio viene potenziato enormemente dal fatto che abbiamo a disposizione uno spazio pubblico con cui possiamo raggiungere decine, centinaia, migliaia e per alcuni milioni di persone, il che non è più legato al riconoscimento che deriva dalla testimonianza diretta legata alla vita vissuta. Oggi noi abbiamo la possibilità di costruirci un Avatar digitale, un alter ego, con cui vogliamo più o meno consapevolmente dare un’immagine di noi stessi che pensiamo possa massimizzare il nostro gradimento sociale. Non è nuovo il desiderio di essere approvati dagli altri, è nuova la metodologia, il dispositivo tecnico che ti consente di farlo e che però, proprio per le sue caratteristiche intrinseche, ha degli effetti quantitativi che poi diventano qualitativi e incidono su chi siamo”.
Gallese è professore ordinario di Psicobiologia presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia – Unità di Neuroscienze dell’Università di Parma. Neuroscienziato, tra i suoi contributi principali vi è la scoperta, assieme ai colleghi di Parma, dei ‘neuroni specchio’ e l’elaborazione di un modello neuroscientifico della percezione e dell’intersoggettività, la ‘Teoria della simulazione incarnata’. La sua produzione scientifica è attestata da oltre 300 pubblicazioni internazionali, dalla pubblicazione di due libri in qualità di autore e di tre libri in qualità di curatore. Ha vinto il ‘Premio Grawemeyer per la Psicologia’ per l’anno 2007, ha ricevuto la Laurea Honoris Causa dall’Università Cattolica di Lovanio (Belgio) nel 2010, l’Arnold Pfeffer Prize for Neuropsychoanalysis a New York nel 2010, il Premio Musatti della Società Italiana di Psicoanalisi nel 2014, e l’Humboldt Forschung Preis dalla Alexander von Humboldt Stiftung, Germania, nel 2019.